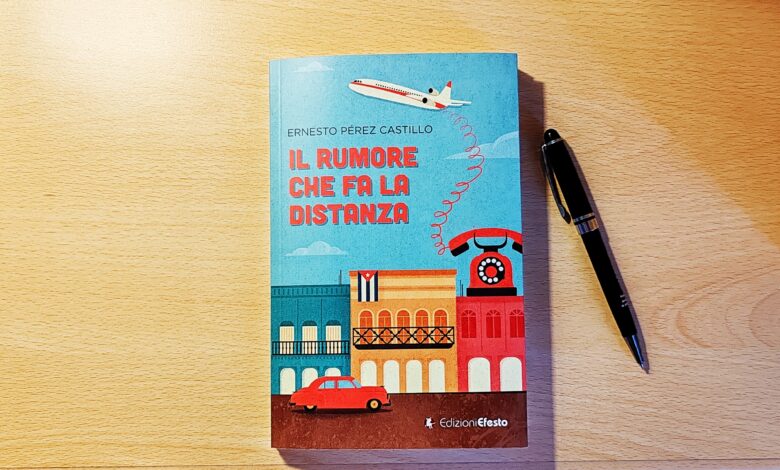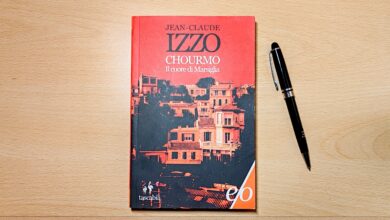Nell’immaginario collettivo quando si parla di migrazione spesso si pensa al trasferimento di masse da un territorio a un altro. Spostamenti di gruppi di persone, dunque, all’interno dei quali risulta difficile definire le identità, se non in base a parametri generali come luogo di nascita e provenienza, lingua parlata e colore della pelle. Ma se si utilizza una grossa lente di ingrandimento ci si renderà conto che la massa sopra citata, ovvero il gruppo, è composta da individui, e il termine migrazione, anche semanticamente, perde quel valore di impersonalità che lo contraddistingue assumendo un significato più intimo.

“Lavorare stanca. Lavorare significa passare otto ore a impacchettare lampadine in una fabbrica. Lavorare è quello che dovrei fare la prossima settimana a Madrid. Lavorare è esattamente il contrario di quello che voglio fare io. Ed è lavoro ciò che mi hanno promesso. Qui non bisogna lavorare, anche se è importante far finta di farlo. D’altra parte, anche loro fanno finta di pagarti. Ma, se ci pensi bene, non è un cattivo affare. In cambio hai un sacco di tempo libero per te”.
Il protagonista del romanzo è un uomo di trent’anni circa, la cui compagna è già partita in direzione Europa. L’obiettivo è ricongiungersi in una città europea ancora da stabilire. Ecco dunque che l’uomo si ritrova da solo, nella calda e afosa Avana, da un lato a riflettere sul significato della migrazione, dall’altro a fare i conti con le implicazioni sociali e psicologiche della sindrome dell’abbandono: perché non se ne va solo chi parte, ma anche chi resta, privato della routine, delle abitudini, degli affetti, del calore della persona che gli stava accanto e che adesso invece dista migliaia di km. Ed è in questo contesto di totale solitudine, in cui anche l’identità inizia a diluirsi a causa dell’assenza imposta dell’altro, in cui ogni gesto inizia ad assumere una forma quasi meccanica, che l’uomo cerca di adoperarsi per ridurre il rumore di quella distanza che inizia a fare male, insinuandosi sotto pelle e a pungere come le spine.
Il rumore che fa la distanza è un romanzo sulla migrazione, in cui Ernesto Pérez Castillo fa coincidere la storia di vita del protagonista con quella collettiva di Cuba: sullo sfondo, infatti, si respira l’atmosfera della Cuba degli anni 90, attraverso la narrazione di fatti sociali e politici che hanno segnato un’epoca e che, naturalmente, non possono essere separati dal racconto degli eventi personali di chi quella Cuba l’ha vissuta in carne e ossa. È dunque la macrostoria che si amalgama con la microstoria in un libro che, con uno stile asciutto e ironico, non risparmia osservazioni agrodolci sulle contraddizioni di un Paese unico al mondo come Cuba e, con un finale decisamente a sorpresa, tenta di decostruire alcuni stereotipi relativi alla narrazione dell’atto migratorio.
Vieni a parlare di libri con tutti noi nel gruppo Facebook The Book Advisor
“Il rumore che fa la distanza” di Ernesto Pérez Castillo, edizioni Efesto. Libri in Pillole.