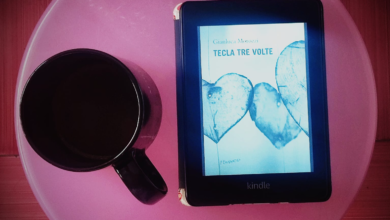L‘acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito, pubblicato da Bompiani, vince il Premio Campiello 2021; stravince, anzi, è il caso di dire, con un distacco già solido dal secondo posto e addirittura fantascientifico dal resto della cinquina. A proposito di cinquina, il titolo ha anche fatto parte delle proposte per il Premio Strega 2021, per il quale era giunto tra i cinque finalisti.

La storia di una famiglia sfortunata, composta da un padre disabile, una madre durissima forse per scelta, forse per necessità, quattro figli da crescere tra cui la protagonista. Questa celerà il suo nome fino alla fine – un nome che è un ossimoro – il tutto sotto lo sguardo indifferente della città.
Da Roma la famiglia si sposta verso un regno molto più fluido, molto più indefinito, nei pressi del lago. Scappano per questioni economiche, rifugiandosi ad Anguillara. Ma la madre pretende che la protagonista del libro continui la sua formazione scolastica a Roma; il paese non le avrebbe offerto occasioni di rivalsa, come quelle che la madre continuerà a ricercare a ogni pagina.
Vedete bene che in questo modo si costruisce un ottimo palco di confronto: il cambiamento a cui viene sottoposta la protagonista di L’acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito è un cambiamento parziale. La ragazzina è costretta a un paragone costante rispetto a come avrebbe potuto essere la sua vita, a com’era e alla vita degli altri. Ma senza potergli opporre un competitore degno, perché il flusso della vita vera, invece, resta immobile, contaminato dalla povertà e dall’amarezza, per molti anni. Citiamo: “Sono una donna giovane e già vecchia, ho perso diritto […] senza averlo mai avuto, come se avessi saltato la mia fermata e ora il viaggio dovesse continuare fino al capolinea”. Così non si integra né in un mondo né nell’altro (chi ha fatto le superiori in una città diversa dalla propria lo sa), restando sempre con un piede dentro e uno fuori.
Digressione mia: questo è un classico nostrano. Abbiamo spezzettato la formazione superiore costringendo ragazzini a un pendolarismo simil-operaio e a convivenze forzose tra tenori di vita e valori differenti in un’età in cui ci si invidia anche un pennarello; il tutto senza l’attenuante di una conoscenza pregressa o della condivisione di valori o vicinanza. Il liceo unico francese o quello americano, per esempio, parti di un corpus municipio-territorio-vicinato-scuola, agevolano l’integrazione e l’appartenenza comunitaria. Noi invece pretendiamo dai giovanissimi che viaggino senza deragliare e osservino senza desiderare; lontani decine di chilometri ogni giorno dalla mediazione di qualunque adulto a cui possa importare. Situazioni talmente prolifiche di spunti che già nella dozzina dello Strega mi pare ci siano stati rappresentati dello stesso tenore, o con lo stesso presupposto.
Dicevamo, la protagonista finisce così per vivere per molti anni una vita frammentata, gran parte spesa sui mezzi di trasporto o lungo la loro metafora, cioè l’attesa. Un mondo grigio e in cui niente è davvero importante, quasi irreale: “Quello che ho fatto per anni è stato aspettare rivoluzioni, slavine, reazioni a catena che portassero come ultimo effetto alla mia ascesa”.
Gli altri mondi che la Caminito sceneggia sono il mondo dell’arrivo e quello di partenza, senza che nessuno dei due sia il vero traguardo o la vera radice. Inoltre i due luoghi hanno sovvertito la situazione iniziale, che bizzarramente – spoiler alert – verrà sovvertita ancora e ancora. Proprio l’appartenenza, l’integrazione e l’empatia passeranno per la protagonista da semplici lacune a miraggi, e non senza conseguenze.
È una situazione complicata da affrontare in un momento di crescita. L‘appartenenza è già qualcosa che l’uomo persegue per vocazione sociale; nell’adolescenza questo bisogno è decuplicato, soprattutto in una famiglia problematica come quella della protagonista. Nello stesso tempo si cerca anche di affermare se stessi; ma bisogna ospitare svariate personalità dentro, per restare se stessi in ambienti diversi e con persone diverse. È come provare a ottenere sempre lo stesso colore mescolandosi però a diverse tinte: se provi a essere uguale a te stesso in tutti gli ambienti, verrai percepito in tre modi diversi; se provi ad adeguarti ad ogni ambiente per essere percepito nella maniera migliore, diventi tre persone differenti: quella che sei a casa, quella che sei fuori, quella che sei nel passaggio. Il prima, il dopo, il mentre.
Se poi detesti la maggior parte di quelle versioni, è facile che cominci ad attrarti quella più narcotica, che anestetizza il dolore che provi nel resto della tua vita. Chi l’ha provata lo sa, che la rabbia è un anestetico. È anche un antidoto, certo, ma non per il dolore; per quello l’unico antidoto è la felicità, miraggio dei borderline, mentre l’aggressività e la rabbia restano un narcotico, forse il migliore.
L’aggressività con cui chi non ha mai posseduto niente difende il suo diritto di possedere possedere qualcosa, è un classico tema dei drammi picareschi. La protagonista di L’acqua del lago non è dolce non sfugge a questa routine; che quel possedere sia riferito a un amore, un’amicizia, una verità e, quando tutto manca, alla vita stessa.
Dal libro:
Noi tre amiche nasciamo come una cosa sgangherata e che mi mette sospetto.
In più non sono tagliata per le amicizie, non ne capisco le dinamiche, le incomprensioni, non so quando bisogna rispondere, quando rimanere in disparte; non posso invitarle a casa mia, non ho nessuno che riesca ad accompagnarmi da loro. Mia madre dice che prima di uscire il pomeriggio dovrò aspettare almeno l’anno dopo; non sono seducente, non porto novità, non ho giochi, non ho trucchi, non ho vestiti da prestare; posso mettere in comune solo le felpe di mio fratello, i pannolini dei gemelli, la sedia a rotelle di mio padre.
Le difficoltà della protagonista non sono lievi, tra quelle economiche e i vari disagi familiari per delle dinamiche che vengono spiegati nel libro. Una fra tutte in casa, la differenza nell’equilibrio dei poteri; nella nuova configurazione post-trasferimento sono molto sbilanciate a favore della madre, con scarsa empatia per il resto della famiglia. Una fra tutte fuori di casa, la disparità tra impegno profuso e risultati ottenuti, sentimentalmente o economicamente che sia.
Questi dettagli vengono fuori con un racconto sempre materiale, poco per evocazione e molto per rappresentazione diretta. Non troverete virgolette in questo romanzo, nei discorsi tra i vari personaggi; ci sono le parole, ecco, questo libro è così. Le parole sono lì per rappresentare i fatti, e i fatti sono piuttosto problematici. Il lettore è chiamato , obbligato ad avere un’opinione; la mia è che – forse perché ci ho trovato molti punti in comune con la mia formazione – mi è piaciuto.
Leggiamo uno stralcio del libro.
Io devo iniziare le scuole medie e scopro da mia madre che in quegli anni Anguillara sta vivendo il suo boom di traslochi dalla Capitale; […] quelli di Roma si stanno mescolando a chi è nato lì e questo impasto crea dissapori, inquietudini, apprensioni.
Chi siamo noi, loro proprio non riescono a capirlo e soprattutto è mistero il motivo che ci ha portati in paese. Di volta in volta noi inventiamo ragioni valide o semplici fantasie; zie nobili, allergie allo smog, l’amore per le strade provinciali, a Roma non si riusciva più neanche a comprare i pomodori; ci piace l’odore delle spighe e delle mucche, amiamo le passeggiate e il trekking, un giorno faremo in bicicletta tutto il perimetro del lago.
La verità su mia madre e la signora Mirella io non la conosco, so soltanto che della nostra infanzia bisogna tacere i dettagli; di nostro padre diciamo che è invalido e non altro, sulla casa diciamo che ci abitiamo e non altro. Non è fingere e non è mentire, è omettere; mia madre ci insegna che raccontare le minuzie, le faccende, le piccolezze di famiglia in paese è molto peggio che affrontarlo nudi con le mani legate.
A Roma secondo mia madre la nostra era una vita da ostaggi, e lei aveva scelto per tutti la migliore delle soluzioni, in modo da non dover più avere a che fare con certa gente, quella che con i soldi non s’è comprata la limpidezza: l’appartamento romano era uno stagno di ranocchie e girini, larve, lombrichi, noi avevamo bisogno di una superficie acquatica su cui veleggiare. Così mi ha convinta, con l’immagine dei velieri, del vento in poppa.
Chi ha lodato questo libro negli ultimo mesi quasi sempre ci ha trovato un palco personale per la propria rabbia; un sentimento sempre più tipico dei nostri anni, per le ingiustizie sociali e per l’indifferenza del resto del mondo. Una repressione che cresce di pari passo e inversamente proporzionale a quanto invece l’espressività online si dilata. La protagonista infatti di rabbia si nutre, della rabbia fa la propria linfa. Una rabbia non sempre rumorosa, non sempre con degli effetti clamorosi, che però non manca mai l’appello: sia come oggetto delle pagine sia come silenzioso background dei fatti narrati.
Paradossalmente, i suoi detrattori hanno trovato che di rabbia invece non ce ne fosse di abbastanza propulsiva per il meglio, che fosse una rabbia che guardava in alto ma mai in basso o nello specifico verso se stessi. Un sentimento che preferiva guardare alle cause e alla sfortuna piuttosto che a un’eventuale evoluzione, come carburante per un cambiamento. Si è sempre più fortunati agli occhi di qualcuno che guarda; basta che il punto di vista sia leggermente più in basso del nostro.
A me, ripeto, è piaciuto. Al massimo posso dire di aver trovato più reazione, che azione; ovvero, molto feedback rabbioso all’indigenza, alla sfortuna, all’infedeltà e alle speranze disattese, alla freddezza parentale e all’assenza di beni, affetti, conforto. Ma eccezion fatta per uno sterile accanimento scolastico, poca azione di risposta, costruttiva, di risoluzione; di certo la protagonista – giovanissima – non è un personaggio che poteva risolversi da sé, ma il suo arco narrativo supera la scuola e tuttavia rimane simile a se stesso. Nel suo dipanarsi invece che compiere la parabola con cui portarci in un punto diverso da dove abbiamo cominciato, si allontana, sparisce fra le nuvole, somigliante al personaggio di partenza. Ma chissà che non fosse l’intento della premiata autrice, anche lei giovanissima, e chissà quanto presente in questa storia – che bisogna sempre leggere e mai giudicare.
Devo alzarmi dal letto alle sei del mattino per essere in classe alle otto e venti, a stento faccio colazione, ingollo latte e due biscotti, ho la pancia stretta, i treni stanno peggiorando; sono carri bestiame, la gente alita contro le porte automatiche, non ha lo spazio per starnutire, si insulta a ogni scossone. Io, una volta scesa, spesso devo iniziare a correre, con lo zaino che balla sulla schiena, perché vedo arrivare il duecentouno dall’altra parte del parcheggio.
L’autobus ha pochi posti a sedere, passa accanto alla mia scuola media che ora mi appare minuta, secca e floscia, una pianta a fine inverno; poi la supera e procede lentissimo, ci sono tratti per colpa dei semafori dove è impossibile pensare di superare i trenta all’ora e altri dove d’improvviso la strada si libera e il traffico pare defluire al modo del sangue nelle arterie migliori.
Ma a volte non basta, certi giorni accumuliamo ritardi e siamo costretti a scendere davanti alla deviazione per il Grande Raccordo Anulare e farcela a piedi fino a scuola. In questo tragitto, faccio slalom tra i gas di scarico delle automobili in coda e mi accorgo della presenza d’un altarino. È Agata a indicarmelo, è recintato con una staccionata, al centro ci sono un mazzo di fiori finti e due fotografie incorniciate in lamiere di ruggine.
Qualcuno ci dice che là è finita la vita di due ragazze in motorino, si sono schiantate anni prima contro il palo della luce, e io penso che sia il presagio di un dispiacere. Doverle incontrare senza conoscerle per il resto dei cinque anni della mia vita e immaginarmi anche io lì, una foto al bordo strada, su cui scorre il fiume dell’indifferenza e dell’urgenza di arrivare a destinazione.
Nella velina della casa editrice oltre alla descrizione del romanzo troviamo questa definizione, molto calzante e profonda a mio vedere:
Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c’è solo il piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le acque immobili di un’esistenza priva di orizzonti.
Gli oggetti posseduti o negati sono un esatto concetto non solo aderente al modello Duemila ma a tutta l’adolescenza, per definire chi è in e chi è out, e la nostra protagonista è senz’altro out. Ma mi piace l’aritmetica spietata che descrive l’avere propedeutico all’essere. Non che mi piaccia il concetto, ma trovo che sia un meschino quanto esatto metronomo della felicità e della realizzazione percepita dai giovanissimi; molto spesso, oggi, anche e meno onorevolmente per i meno giovani.
“L’acqua del lago non è mai dolce” di Giulia Caminito, edizioni Bompiani, 2021. Anonima Lettrice Italiana.