Bentornati alla rubrica “i libri illeggibili”. Giunti al nostro sesto appuntamento, è ormai chiaro a tutti, che esistano un bel po’ di libri destinati a non essere mai più letti, eppure, vi siete mai chiesti quanti ancora ne sarebbero potuti sparire dalle nostre librerie, se persone quali bibliotecari, copisti, filologi, storici o restauratori, non avessero svolto al meglio il proprio lavoro? Sicuramente è a loro che dobbiamo i nostri più sinceri ringraziamenti… ma, se vi dicessi che, allo stesso modo, dovremmo essere grati anche ad alcuni buoni amici che alla fine non si sono rivelati tali, ad editori sleali o a familiari fedifraghi? Tra i nostri cari libri, infatti, se ne nascondono alcuni, che, in realtà, non avremmo mai dovuto poter leggere. Non si tratta di volumi proibiti o censurati, ma di opere che non avrebbero mai dovuto essere stampate e divulgate.
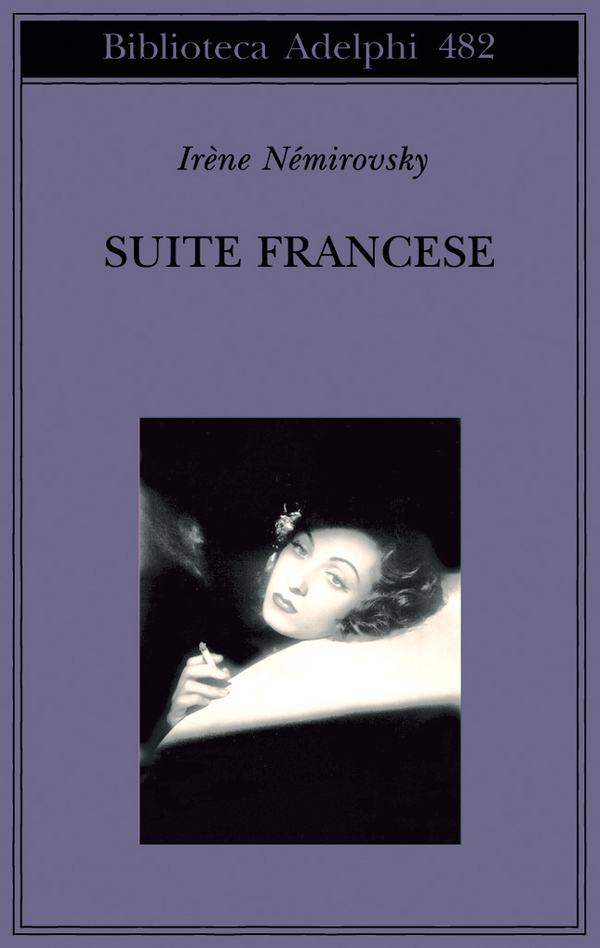
Parlando di un libro pubblicato solo dopo la morte del suo autore, tendiamo sempre a pensare ad un’opera che lo scrittore non ebbe tempo o modo di far pubblicare in vita. È il caso Irène Némirovsky, che già nel 1942 si rese conto che non avrebbe mai potuto portare a termine “Suite francese”, per cui scrisse al suo editore: “Caro amico… non mi dimentichi. Ho scritto molto. Saranno opere postume, temo, ma scrivere fa passare il tempo.”. Pochi mesi dopo fu deportata ad Auschwitz, dove morì di febbre tifoide. Il romanzo verrà pubblicato, incompleto (avrebbe dovuto avere cinque parti, ma l’autrice riuscì a scriverne solo due) nel 2004, quando la figlia maggiore ne ritrovò i manoscritti.
Non visse abbastanza neanche il povero Michail Bulgakov, il cui “Il maestro e Margherita” fu pubblicato interamente dopo quasi 40 anni dalla sua prima stesura, nonché 26 anni dopo la morte dell’autore. La prima versione del romanzo fu completata, infatti, nel 1928, ma quanto Bulgakov venne informato dell’imminente censura che avrebbe prodotto notevoli tagli all’opera, decise di distruggerla dandola alle fiamme. Fortunatamente per noi, si rimise presto nuovamente al lavoro: riscrisse il romanzo e lo completò nel 1937, anche se continuò a “ripulirlo” per anni con l’aiuto della sua terza moglie. Lavorerà ad una quarta stesura fino alla sua morte, nel 1940, che verrà ultimata dalla moglie un anno più tardi. A conclusione dell’opera, nonostante le numerose modifiche già apportate, ne furono pubblicate solo versioni ulteriormente censurate. Per la prima edizione integrale si dovrà attendere fino al 1967. Meglio tardi che mai.

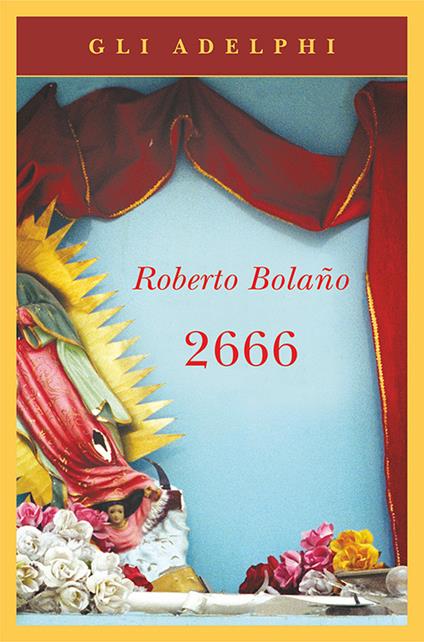
Poco tempo a disposizione anche per Hans Fallanda ed il suo “Ognuno muore solo” (pubblicato solo due settimane dopo la morte dell’autore), James Agee che lavorava ancora al suo “Una morte in famiglia” quando fu colto da infarto (il romanzo gli valse anche un Pulitzer postumo), Stieg Larsson, il giornalista svedese che deve la sua fama alla trilogia “Millennium” pubblicata dopo la sua prematura scomparsa causata da un infarto (la serie avrebbe dovuto includere dieci romanzi secondo il progetto iniziale), Roberto Bolaño, che non vide la pubblicazione del suo “2666”, stampato dopo la sua morte sopraggiunta per insufficienza epatica, mentre già lavorava ad un ultimo romanzo rimasto incompiuto “El Tercer Reich”.
Eppure, non tutti i libri postumi rispecchiano i desideri dei rispettivi autori. Alcuni di essi, infatti, rifiutarono categoricamente l’idea di far pubblicare alcune delle proprie opere (se non tutte) ed in molti casi, espressero chiaramente in testamenti, lettere o note, la volontà che queste venissero distrutte in seguito alla propria morte. Le motivazioni di una così drastica decisione sono tante, a partire dalla più ovvia: la paura di fallire, l’ansia di presentare al pubblico qualcosa che possa risultare deludente. Ciò ne ha impedito la divulgazione? Assolutamente no, basti pensare che un primissimo esempio di eccessiva autocritica fu Virgilio, desideroso di dare alle fiamme l'”Eneide” da lui considerata imperfetta e incompleta (cari studenti, frenate l’entusiasmo, perché l’opera fu salvata). (In foto: Mosaico di Virgilio al Museo Nazionale del Bardo) (2007, Giorces, CC BY 2.5, Wikimedia Commons)

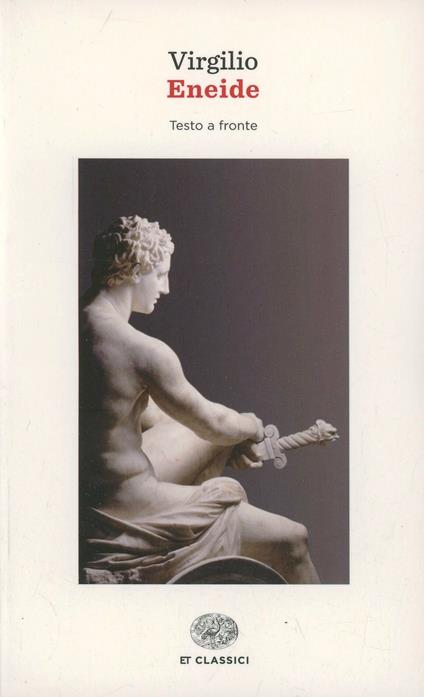
Publio Virgilio Marone, noto semplicemente come Virgilio, iniziò la stesura dell’Eneide dopo il 29 a.C. e vi lavorò per gli ultimi dieci anni della sua vita, senza, peraltro, giungere ad una revisione definitiva. Nei 12 libri che compongono il poema, vi sono, infatti, alcune incongruenze, lacune, piccole contraddizioni e 58 versi non finiti. Nel 19 a.C. Virgilio decise di andare in Grecia e in Asia per dedicarsi al compimento del poema, ma pregò l’amico Vario Rufo, di bruciare l’intera opera, qualora non fosse riuscito a completarla. Secondo la tradizione, confidò all’amico, il suo grande timore di lasciare il poema incompiuto e non ancora revisionato, asserendo, inoltre, che il passo del libro VIII sui rapporti matrimoniali di Venere e Vulcano non era più di suo gradimento. Presumibilmente aveva intenzione di modificare quella scena per adattarla meglio ai valori morali romani. Pochi mesi dopo la partenza, però, Virgilio fece ritorno gravemente malato, e quando l’amico rifiutò di bruciare il poema, chiese il manoscritto per bruciarlo egli stesso. Nessuno volle obbedirgli, e nonostante la richiesta di distruggere l’opera, fosse ribadita in un testamento scritto dal poeta, venne pubblicata così com’era, per ordine dell’imperatore Ottaviano Augusto. Dobbiamo quindi ringraziare un pessimo esecutore testamentario, se oggi possiamo leggere una delle opere più importanti di tutta la latinità.
1789, sono invece le poesie che avremmo perduto per sempre, se Lavina Dickinson avesse rispettato le ultime volontà della sorella Emily. Nata in una famiglia borghese di tradizioni puritane, Emily Elizabeth Dickinson, fu molto legata alla sorella minore, la quale, dal canto suo, amò tanto Emily, quanto il suo enorme talento poetico. Pochi altri affetti riempirono la vita della famosa poetessa ed uno di questi, la legò indissolubilmente all’amica di infanzia e cognata Susan Huntington Gilbert, una delle poche persone ad aver letto alcune sue poesie e con la quale intrattenne una copiosa corrispondenza, di oltre 300 lettere. Si trattò di un vero e proprio amore platonico, che l’autrice stessa paragonò a quello di Dante per Beatrice. Diversi biografi di Emily Dickinson ritengono che centinaia delle sue poesie d’amore furono scritte interamente per Susan. Non si trattò, comunque, dell’unica esperienza amorosa della poetessa, che si invaghì prima di un reverendo già sposato e poi di un anziano amico del padre che dovette allontanare a causa di tensioni familiari. Tali delusioni sentimentali, unite al dolore per la morte del nipote di 8 anni e a quella del suo ultimo amato, le causarono disturbi nervosi di tipo agorafobico ed ansia sociale, sopraggiunte insieme ad una fastidiosa malattia agli occhi (o forse ad una forma di epilessia). Ciò portò Emily a rinchiudersi nella propria camera della casa paterna, e se negli anni della sua giovinezza lasciò leggere a qualcuno (seppur a pochi) alcune delle sue poesie, dai 50 anni divenne sempre più rigida nel rifiuto di far conoscere le sue opere. Smise di frequentare gli amici, iniziò a vestirsi solo di bianco e dedicò tutti i suoi sforzi a sviluppare lo straordinario compendio per cui è nota, ma non prima di aver fatto promettere alla sorella Lavinia, che avrebbe bruciato ogni suo scritto, dalle poesie alla corrispondenza, non appena avesse lasciato questo mondo. Emily Dickinson si ammalò di nefrite nello stesso luogo in cui era nata, nel Massachusetts, e morì nel maggio 1886 all’età di 55 anni. Fu allora che Lavinia scoprì le diverse centinaia di versi scritti su foglietti ripiegati e cuciti con ago e filo dalla sorella. Così, nonostante la promessa fatta, nel 1890, ottenne la pubblicazione del primo volume di poesie. In seguito vennero pubblicati oltre trecento componimenti trovati dalla nipote, ed altri ancora furono ricavati dalle lettere, nonché dai biglietti che scrisse per accompagnare i doni fatti a parenti ed amici. Insomma, un’immensa eredità letteraria, per un’autrice che non ebbe praticamente alcun riconoscimento durante la sua vita, condotta, peraltro, quasi in totale solitudine, fatta eccezione per quella cara sorella che, seppur a fin di bene, decise, infine, di non esaudire il suo ultimo desiderio. Mai una gioia, diremmo oggi.
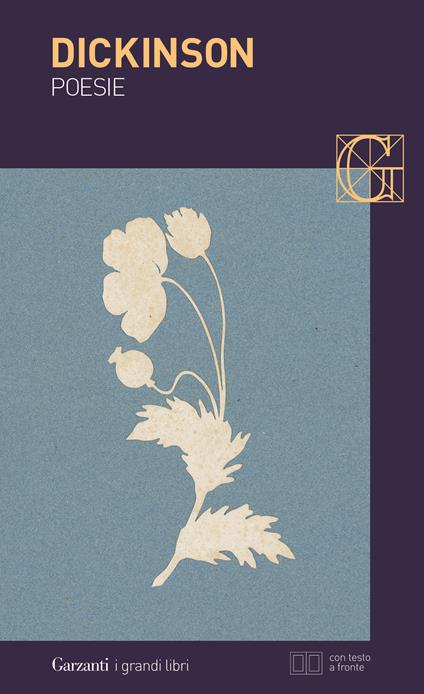
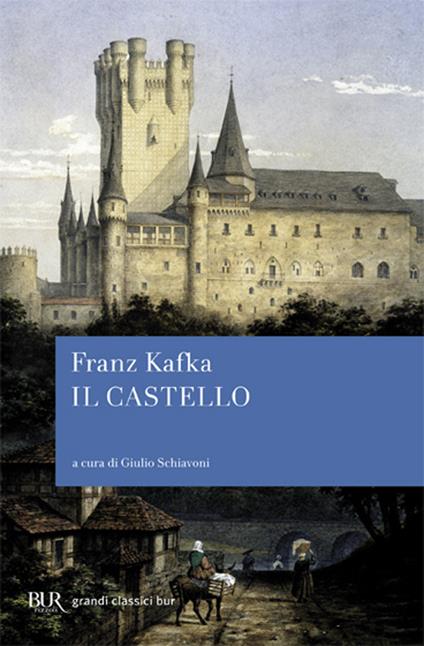
“Carissimo Max, la mia ultima richiesta: tutto quello che lascio dietro di me… diari, manoscritti, lettere (mie e di altri), bozze e così via, [sono] per essere bruciate e non lette”. Questa, l’inequivocabile nota che Franz Kafka lasciò al suo caro amico Max Brod prima di morire, il quale, naturalmente, ignorò le volontà dell’autore e fece pubblicare postumi, alcuni dei i suoi più importanti romanzi, seppur incompiuti, tra i quali “Il processo”, “Il castello” e “Amerika”. Durante la sua vita, infatti, Kafka pubblicò solo una manciata di racconti brevi oltre a qualche opera singola come “La metamorfosi”, che ricevettero modesta attenzione da parte della critica. Ciò non aiutò il fragile animo dell’autore, che già godeva di poca autostima, vivendo nel costante timore che la gente lo potesse trovare, per qualche ragione, mentalmente e fisicamente ripugnante. Secondo alcuni studiosi, Kafka, potrebbe aver sofferto di un disturbo schizoide della personalità, il quale, lo avrebbe costretto a lunghi periodi di angoscia che gli procurarono depressione, episodi di anoressia nervosa e tendenze suicide, oltre ad un rapporto conflittuale e ambiguo con il corpo e la sessualità. Insomma, Kafka, afflitto dall’insicurezza, bruciò molti suoi scritti e, quando si rese conto che il suo stato di salute lo avrebbe condotto ad una prematura morte (avvenuta nel 1924 a soli 41 anni), consegnò tutti i suoi lavori, sia editi che inediti, accompagnati dalla famosa nota, all’amico e curatore Brod. Per tutta risposta, quest’ultimo, pubblicò, nei 10 anni successivi la morte dell’amico, tutti i suoi romanzi e le sue raccolte, ma tenne per sé i manoscritti originali ed ancora molti altri scritti, di cui alcuni, a tutt’oggi inediti.
“Si raccoglie ciò che si semina” recita un vecchio detto, ed in effetti il traditore Brod, venne presto ripagato con la sua stessa moneta. Quando fuggì in Palestina nel 1939, per allontanarsi dall’Europa nazista, portò con sé i manoscritti kafkiani. Quasi 30 anni dopo, prima di morire, li lasciò alla sua segretaria ed amante, Esther Hoffe, perché li consegnasse alla National Library of Israel. Ma anche questa volta, la storia, vide perpetrarsi un tradimento: le volontà di Brod non vennero rispettate, Esther vendette alcuni manoscritti a collezionisti privati (tra i quali “il Processo” venduto all’asta per una cifra milionaria) e conservò gelosamente il resto, per le due figlie Ruth ed Eva. Quando nel 2007, Esther morì, iniziò la lunga battaglia legale delle figlie con la Biblioteca nazionale di Israele, la quale sostenne che i manoscritti fossero diventati proprietà della nazione d’Israele, fin da quando Brod emigrò nella Palestina britannica nel 1939. Nel 2016 la Corte suprema israeliana stabilì che gli scritti di Kafka appartenessero alla Biblioteca Nazionale. In segno di lutto e protesta, l’82enne Eva Hoffe (rimasta sola dopo la morte di Ruth), si fece rasare i capelli a zero, sostenendo, peraltro, che i costi del processo, l’avessero ridotta in miseria. Ad ogni modo, dopo la sentenza, Eva dovette aprire agli studiosi le porte della propria abitazione, perché recuperassero i preziosi documenti: alcuni furono trovati stipati in un frigo rotto, altri erano stati graffiati e inzuppati dall’urina dei suoi gatti. Furono necessari ancora alcuni anni per recuperare tutti i documenti conservati all’estero, eppure, a tutt’oggi, si ritiene che manchino scritti appartenuti a Brod, che, presumibilmente, la famiglia Hoffe, avrebbe nascosto da qualche parte, ma non si sa esattamente dove. A questi, si aggiungono i 20 libri di appunti e le 35 lettere, che Kafka lasciò alla sua ultima amante, Dora Diamant, la quale, come Brod, ignorò i desideri dell’autore, conservando segretamente gli scritti anche dopo la sua morte. Questi furono confiscati dalla Gestapo nel 1933 e mai più ritrovati. Dunque, ancora una volta, è una lunga serie di tradimenti, che ci consente di comprendere (quasi) appieno l’opera del celebre scrittore boemo. Un male che potremmo considerare necessario, anche se, in questo caso, dobbiamo ammettere, che i vari protagonisti di tutta la vicenda, si lasciarono prendere un po’ troppo la mano.
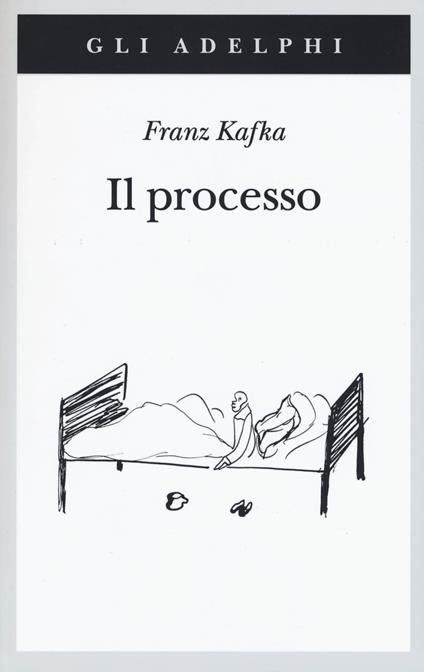
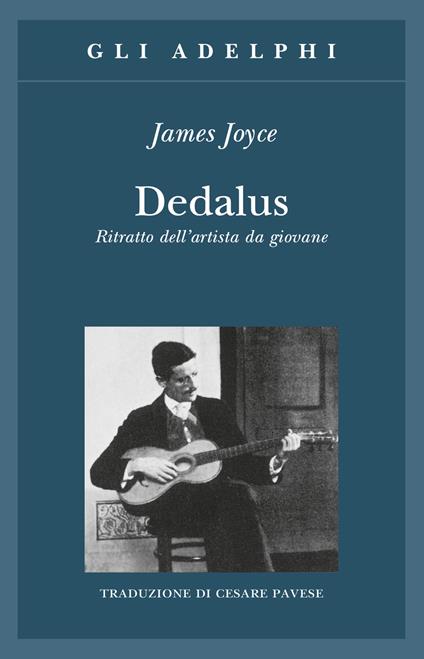
Ma perché gli autori, riponevano tanta fiducia nei posteri e non provvedevano, piuttosto, a distruggere da soli le proprie opere sgradite? Ci provò (e quasi ci riuscì) James Augustine Aloysius Joyce. È una storia semileggendaria, quella secondo la quale, il celebre scrittore, poeta e drammaturgo irlandese, esasperato per i continui rifiuti degli editori (venti, a quanto pare), avrebbe gettato nel fuoco il manoscritto del romanzo “Stephen Hero”. Si narra che furono la compagna Nora Barnacle e sua sorella ad infilare, letteralmente, la mani tra le fiamme, rischiando gravi ustioni, per recuperare almeno una parte dell’opera. Sopravvissero due blocchi di pagine non consecutive: uno di essi, rimase in possesso del fratello di Joyce, mentre la parte restate, più corposa, fu consegnata, in seguito, dallo stesso autore alla Shakespeare & Company. Parte dello “Stephen Hero” confluì nel successivo romanzo semiautobiografico “Ritratto dell’artista da giovane” (conosciuto in Italia anche come Dedalus), che finalmente vide la pubblicazione. Se la storia del manoscritto bruciato sia reale o meno, non possiamo saperlo, fatto sta, che solo nove anni dopo la morte dell’autore, la casa editrice statunitense New Directions, riuscì a recuperare entrambi i blocchi, che pubblicò nonostante si trattasse solo di frammenti con molte parti mancanti. Peccato che nessuno dei venti editori a cui fu presentata l’opera originale, ne riconobbe subito il valore. Forse mancava il fascino delle bruciature.
A riuscire a distruggere completamente la propria opera (ad eccezione di due capitoli), fu, invece, lo scrittore e drammaturgo russo Nikolaj Vasil’evič Gogol’. Il padre del realismo russo iniziò ufficialmente a scrivere racconti già all’età di 16 anni, ma quando pubblicò, sotto uno pseudonimo, il suo primo idillio in versi, questo venne subito stroncato dalla critica. In reazione ai giudizi negativi, Gogol’, comprò tutte le copie della rivista su cui era stata pubblicata la sua opera e le bruciò. Ma la vera e propria opera di distruzione, avvenne quando nel 1852, poco prima della sua morte, diede alle fiamme il secondo volume del romanzo “Le anime morte”. Durante il suo soggiorno in Italia, Gogol’, restò eccezionalmente colpito dalla lettura della Divina Commedia, tanto che pensò di realizzare un’opera improntata al vero spirito russo, suddivisa in tre volumi, corrispondenti a inferno, purgatorio e paradiso danteschi. Iniziò, così, subito a lavorare al romanzo “Le anime morte” che avrebbe rappresentato solo la prima parte della trilogia, nella quale veniva descritta la dimensione morale più bassa della Russia. Gran parte del libro fu scritto proprio ai tavoli dell’Antico Caffè Greco di Roma, dove tuttora è conservata una targa. Ai personaggi spregevoli descritti in questa prima parte (l’inferno), avrebbero dovuto fare da contraltare delle figure più edificanti nella seconda (il purgatorio), fino ad arrivare ad un finale ideale che avrebbe dovuto indicare, allegoricamente, una sorta di percorso redentivo per l’intero popolo russo (il paradiso). Il primo romanzo fu pubblicato nel 1842. Tre anni dopo, Gogol’, fece ritorno a Roma per lavorare al secondo volume, ma non riuscì mai a realizzarne una versione che lo soddisfacesse. Fervente religioso fin da bambino, l’autore, rientrò in patria, dove strinse una forte amicizia con un fanatico religioso. Questi finì solo per aggravare le nevrosi dell’autore, il quale, si convinse che la mancanza di ispirazione per il secondo volume, fosse un segnale di Dio che non approvava il suo lavoro. Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 1852 decise, quindi, di bruciare il manoscritto prodotto in Italia, di cui si salvarono solo due capitoli. Morì pochi giorni dopo indebolito dai lunghi periodi di digiuno e di penitenza.
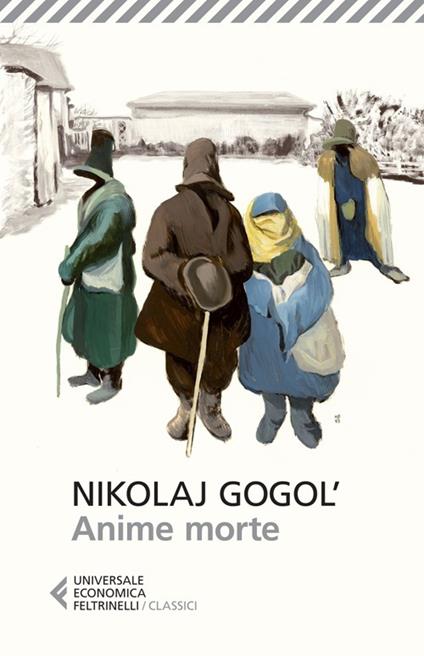
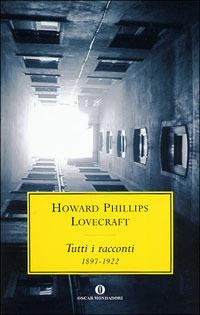
Autonomo ed efficiente, fu, anche, Howard Phillips Lovecraft, scrittore, poeta, critico letterario e saggista statunitense, che nel 1908, all’età di 18 anni, distrusse le sue opere giovanili ritenendole orrende. L’autore, riconosciuto tra i maggiori scrittori di genere horror, ebbe un’infanzia ed una giovinezza già piuttosto travagliate, a partire dal padre affetto da una grave psicosi, che morì nell’ospedale in cui fu ricoverato per anni, quando Lovecraft aveva solo otto anni. Venne quindi cresciuto dalla madre e dal nonno, appassionato di letteratura gotica. A 10 anni fu vittima dei primi esaurimenti nervosi, forse provocati dall’atteggiamento iperprotettivo della madre, che arriverà al punto di vietare al bambino di uscire per via della sua eccessiva bruttezza. A quel tempo, Lovecraft, aveva già scritto numerose poesie e racconti realistici, ma dopo la morte del nonno, le difficoltà economiche, la salute malferma e la caduta da un’impalcatura (in seguito alla quale soffrirà di mal di testa per tutta la sua vita), si ritirò definitivamente dagli studi, ed i suoi esaurimenti divennero sempre più frequenti. Nel 1908, dopo l’ennesimo collasso nervoso, decise di distruggere quasi tutta la sua produzione giovanile, disgustato dalla maggiore età che aveva appena raggiunto e dai suoi scritti. Sembra che tale repulsione, fiorì nell’autore sotto la spinta materna. A quanto pare, infatti, Lovecraft, conservava gelosamente i quaderni nei quali aveva raccolto le storie ispirate al fantastico e all’orrido, scritte già a partite dai cinque o sei anni. A 18 anni compiuti, fu indotto a smettere dalla madre, che demoralizzò a tal punto il figlio e la sua opera, da spingerlo a strappare quasi tutte le storie fino ad allora prodotte. Quale che sia stata la causa di tanta avventatezza, ad oggi, dei numerosi scritti giovanili di Lovecraft, ne restano, solo cinque (tra i quali “La piccola bottiglia di vetro” scritta all’età di 7 anni).
Se la presenza particolarmente “ingombrante” della madre di Lovecraft ci ha impedito di leggere alcuni dei suoi lavori, dobbiamo, invece, ringraziare la madre di John Toole perchè solo grazie alla sua grande tenacia e determinazione, l’opera del figlio fu finalmente pubblicata. Anche l’infanzia di Toole, come quella di Lovecraft, fu dominata dalla figura materna, nonostante, il primo, vivesse con entrambi i genitori. Thelma Toole, tenne il figlio in una sorta d’isolamento dai coetanei, con i quali raramente gli era permesso giocare perché ritenuti non all’altezza della sua genialità. Negli anni ’60, Toole, scrisse il romanzo “Una banda di idioti” ed inviò il manoscritto ad un editore di New York, il quale, dopo un’accoglienza inizialmente entusiasta, si rifiutò di pubblicarlo poiché il libro “in realtà non parla di niente”. Il giovane autore cadde, così, in depressione, perdendo ogni speranza per un romanzo, che egli considerava il suo grande capolavoro. In seguito, Toole, lascerà il lavoro, la sua città e si abbandonerà all’alcol. Il 26 marzo 1969, John Kennedy Toole, venne ritrovato morto per asfissia, seduto nella sua auto, con un tubo tra la marmitta e l’abitacolo. Aveva 32 anni. La signora Toole si imbatté per caso, poco dopo il suicidio del figlio, in una copia carbone rovinata del manoscritto. La portò immediatamente da più di otto editori, che la ignorarono del tutto, ma la donna non si arrese, e per quasi 10 anni, continuò a cercare qualcuno disposto a pubblicare l’opera del figlio. Nel 1976, dopo molte insistenze, riuscì ad ottenere un incontro con l’autore e professore Walker Percy, il quale, finalmente, dopo un’iniziale ritrosia, riconobbe la genialità del romanzo. Nel 1980, il libro fu pubblicato per la prima volta a spese di Percy e, l’anno successivo, al suo autore, fu conferito postumo il Premio Pulitzer per la narrativa, evento che annoverò definitivamente il capolavoro tra i classici della letteratura americana del XX secolo. Nonostante non si tratti propriamente di una storia a lieto fine, almeno per una volta, possiamo ringraziare la signora Toole per aver salvato l’opera del figlio, senza sentirci troppo in colpa per qualche ultima volontà tradita.
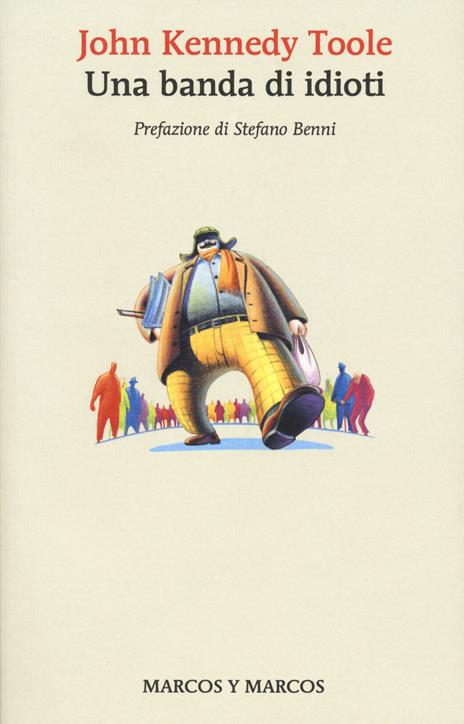
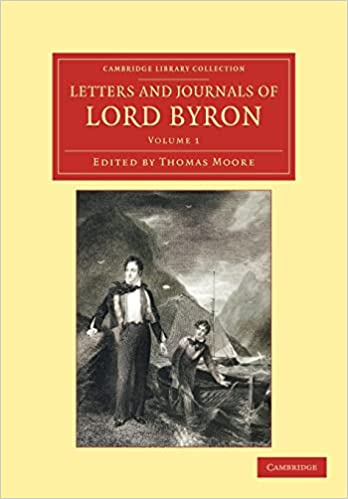
A proposito di ultime volontà, anche gli autori che avrebbero desiderato una semplice pubblicazione postuma, non sempre ebbero vita facile (o meglio, un sereno riposo eterno, in questo caso). In pole position troviamo senza dubbio George Gordon Noel Byron, VI barone di Byron, vittima di uno dei più grandi crimini letterari della storia. Il nobile, poeta e politico britannico, scrisse un libro di memorie tra il 1818 e il 1821 che consegnò al poeta Thomas Moore, suo esecutore testamentario ed amico, con la clausola che venisse pubblicato solo dopo la sua morte. In realtà l’opera non fu mai stampata ed il manoscritto venne probabilmente distrutto. Già l’amicizia tra Byron e Moore nacque in circostanze abbastanza particolari, quando quest’ultimo sfidò a duello l’editore, che ebbe l’ardire di criticare uno dei suoi lavori. L’incontro fu interrotto dall’arrivo delle autorità ed entrambi i contendenti vennero arrestati. Iniziò, così, a girare un pettegolezzo, secondo il quale, all’avversario del poeta era stata consegnata per il duello, una pistola non carica. La diceria tormentò Moore e fu motivo di beffeggio per diversi anni, tanto che anche Lord Byron, scrisse il racconto “Leadless pistol” (pistola senza piombo) in cui “i proiettili, così come il coraggio dei duellanti, erano evaporati”. Moore, di fronte a questa ennesima derisione, reagì inviando una lettera all’autore, in cui affermava che se l’affronto non fosse stato chiarito, lo avrebbe sfidato a duello. Quando i due, alla fine, si incontrarono risolsero la controversia e divennero ottimi amici. Anni dopo, si ritrovarono per l’ultima volta a Venezia, dove Byron, affidò all’amico le sue memorie, ma nel 1824, quando il Lord morì, Moore, si lasciò convincere dalla famiglia, a promettere che non le avrebbe mai divulgate. In effetti, il contenuto scandaloso del libro, preoccupò non poco il poeta, che infine, decise di pubblicare solo la “Letters and Journals of Lord Byron, with Notices of his Life” eliminando dall’opera originale le parti più sconvenienti. Il manoscritto, invece, fu venduto all’amico ed editore John Murray, il quale, preoccupato per il suo contenuto scabroso, decise probabilmente di distruggerlo. Ma quale fu il motivo di tanto clamore? A quanto pare, i dettagliati racconti delle avventure amorose di Byron, inclusa quella incestuosa con la sorellastra Augusta. Dal 1812, infatti, folgorato dal successo, il poeta, incarnò gli ideali di un tenebroso dandy, ed intraprese una lunga serie di relazioni con donne come l’eccentrica Caroline Lamb, che lo avrebbe poi descritto come “pazzo”, cattivo e pericoloso da frequentare. Ma, contemporaneamente alla Lamb, divenne un intimo anche della sorellastra Augusta (figlia del suo stesso padre e della sua prima moglie) con la quale ebbe un’intensa relazione sentimentale e fisica. Da questo rapporto nacque una bambina battezzata con il cognome del marito della donna. Tutta la situazione, si trasformò ben presto in un enorme scandalo, cosicché, Byron, decise di sposare una cugina della Lamb, al fine di risistemare la sua situazione sociale. I due ebbero anche una figlia, ma le vicende coniugali, già tempestose, si deteriorarono quando Byron riprese gli intimi rapporti con Augusta. Nel frattempo, le ipotesi relative alla ormai conclamata bisessualità dello scrittore si diffusero negli ambienti colti del tempo. Ad ogni modo, questi e altri scandali di ordine morale (fu accusato di incesto, adulterio, omosessualità, sodomia, amore libero ed altro ancora) furono alla base del crescente sdegno dell’aristocrazia londinese, nonché della scelta di Moore e Murray, che cercarono di evitare ulteriori scandali, anche dopo la morte dell’amico. Peccato che Lord Byron fosse circondato da amici tanto morigerati (si fa per dire, perchè l’amore incestuoso di Byron, desterebbe scandalo anche tra i contemporanei) o, ad oggi, avremmo potuto conservare nelle nostre librerie, delle memorie particolarmente succose.
Vittima di un eccesso di pudicizia, quindi, Lord Byron, così come fu vittima di un eccesso di zelo Arthur Schopenhauer. Il filosofo tedesco considerato uno dei maggiori pensatori dell’epoca moderna, non molti anni prima della sua scomparsa, strinse una profonda amicizia con l’avvocato e romanziere Wilhelm von Gwinner, che sarà, poi, il suo primo biografo. Nel 1858, alla morte di Martin Emder, esecutore testamentario e caro amico di Schopenhauer, l’incarico passò a Gwinner, che sarà la persona più vicina al filosofo nell’ultimo periodo della sua vita. Nonostante la schiera dei discepoli fosse già iniziata a crescere, infatti, in quegli ultimi anni, la vita del filosofo fu abbastanza ritirata. Conduceva lunghe passeggiate, cenava sempre nello stesso ristorante e leggeva riviste scientifiche, il tutto in compagnia del suo amatissimo barboncino Butz, al quale, talvolta si rivolgeva chiamandolo “signore” o lo riprendeva dicendo “tu, umano” quando si comportava male. L’unico che riusciva ad interrompere questa tranquilla routine, era, appunto, Gwinner, con il quale, Schopenhauer si intratteneva parlando di politica e della questione dell’unità d’Italia. Questi, alla morte dell’amico, avvenuta nel 1860, decise di bruciare alcune delle sue opere, per le quali non gli erano state lasciate istruzioni. Per quale motivo lo fece? Non è chiaro, in effetti. Probabilmente credette che il filosofo non volesse essere ricordato per taluni scritti mai pubblicati, alcuni dei quali, si dice fossero un po’ spinti. Gwinner, confessò il fatto, solo quando iniziarono le ricerche di un famoso vademecum. Schopenhauer, infatti, non aveva mai nascosto, a parenti ed amici, l’esistenza di un manuale che era solito chiamare “Eis heauton”, ma dopo la sua morte, nessuno ne trovò traccia. Gwinner, sostenne di averlo distrutto per volontà dello stesso autore, ma se questa affermazione fosse veritiera o meno, non possiamo saperlo. Fortunatamente, il romanziere, prima di ricorrere al fuoco, utilizzò le pagine del vademecum per tracciare la biografia del defunto. Alcuni passi furono interamente copiati dal volume destinato alle fiamme, tanto che fu possibile ricostruire per congettura parte del testo originale, oggi pubblicato con il titolo “L’arte di conoscere se stessi”. Cosa altro ci fosse in questo libro “segreto” tra annotazioni, ricordi, riflessioni, massime e citazioni, non è noto, così come non avremo mai modo di sapere se Gwinner, volle effettivamente rispettare le volontà dell’amico o se semplicemente cercasse di tradirlo, rubando parti della sua opera, per scrivere la propria. In effetti, quando si è a corto di ispirazione, un aiutino di Schopenhauer non deve essere male.


Se pensate che episodi del genere, siano da relegare al passato meno recente, vi sbagliate. Era il 1939 quando Roberto Pozzi rimaneggiò alcune poesie della figlia e ne occultò molte altre, prima di permettere che venissero stampate postume. Antonia Pozzi, poetessa italiana, nacque a Milano, figlia di un importante avvocato e della contessa Cavagna. Frequentò il liceo classico e all’età di 15 anni, conobbe Antonio Maria Cervi, professore di latino e greco, di cui si innamorò profondamente. Cervi di trasferì l’anno successivo a Roma, ma continuò a frequentare la famiglia Pozzi, tanto che fece loro da guida, durante le vacanze pasquali tra Napoli e Roma. Nel 1930, quando Antonia aveva ormai 18 anni, nonostante la distanza, tra i due, nacque un legame sentimentale fortemente osteggiato dalla famiglia di lei. Questi fatti sono, in realtà, solo frutto di una ricostruzione della vicenda, basata su testimonianze di amici e solo in parte desunta dal diario della poetessa, sul quale, però, non si può fare molto affidamento, visto che fu sottoposto, alla morte di Antonia, ad ampi tagli e rimaneggiamenti, tanto da presentarsi, oggi, evidentemente lacunoso. Fatto sta, che i coniugi Pozzi si opposero ad una relazione, secondo loro, poco prestigiosa, e quindi, non adatta alla figlia. Proprio a questi anni risalgono le prime liriche della giovane, ispirate principalmente alla sofferta relazione, che resterà, per Antonia, sempre fonte di grande tormento, nonostante i numerosi viaggi studio che intraprese per volontà dei genitori, i quali cercarono in ogni modo di allontanarla da Cervi. In seguito, la scarsa attenzione che ricevettero le sue poesie nell’ambiente universitario, i giudizi poco lusinghieri del filosofo Enzo Paci, e la naufragata speranza di iniziare una relazione con il filosofo Dino Formaggio, condussero la poetessa al suicidio. Il 3 dicembre 1938, Antonia Pozzi fu trovata, a soli 26 anni, agonizzante dopo aver assunto una forte dose di barbiturici. Morì quello stesso giorno. A parte un breve saggio, tutte le opere della poetessa, vennero pubblicate postume. La prima e più ricca raccolta dei suoi componimenti, è “Parole”, che comprende circa trecento poesie. La prima edizione, pubblicata un anno dopo la morte della poetessa, fu curata proprio dal padre Roberto, il quale, spinto probabilmente dal desiderio di proteggere la memoria della figlia, soprattutto in merito al rapporto con Cervi, occultò diverse poesie, quindi tagliò e rimaneggiò pesantemente i versi di molte altre. Dovremo aspettare fino al 1989, per l’edizione Garzanti, in cui furono ripristinati, laddove possibile, buona parte dei versi originari, anche se alcune poesie, restano a tutt’oggi inedite.
Ancora più recente è il caso di Sylvia Plath, nota anche con lo pseudonimo di Victoria Lucas. La scrittrice e poetessa statunitense dimostrò un talento molto precoce, tanto che pubblicò la sua prima poesia all’età di otto anni. Nello stesso anno, suo padre morì e tale perdita lasciò un segno indelebile nell’animo della scrittrice, la quale soffrì per tutta la sua vita adulta di una grave forma di depressione. All’età di 21 anni tentò per la prima volta il suicidio in seguito ad una crisi che raccontò nel romanzo semiautobiografico “La campana di vetro” pubblicato sotto il suo pseudonimo. Dopo il ricovero in un istituto psichiatrico, conobbe, nel 1956, a Cambridge, il poeta inglese Ted Hughes, di cui presto si innamorò. La relazione tra i due (che si sposarono meno di 4 mesi dopo), fu fin da subito particolarmente burrascosa. Dopo la nascita della prima figlia, la Plath, subì un aborto spontaneo a seguito di un episodio di violenza fisica da parte del marito, come racconterà in una lettera indirizzata al suo terapista. Dopo la nascita del secondo figlio, la coppia si separò definitivamente. In quel periodo Sylvia, completò la sua seconda raccolta di poesie “Ariel” che venne, però, pubblicata alterata da Hughes, due anni dopo la sua morte. Solo nel 2004, la figlia Frieda, diede alle stampe la versione originale, con il titolo “Ariel: The Restored Edition”. L’inverno tra il 1962 e il 1963 fu molto duro, la mancanza di soldi, la solitudine e la salute dei figli spesso malati cominciarono a diventare un peso per la scrittrice, che cadde nuovamente in depressione. Nel febbraio 1963, Sylvia Plath si tolse la vita: sigillò porta e finestre della cucina ed inserì la testa nel forno a gas, non prima, però, di aver preparato la colazione ed aver spalancato la finestra della camera dei suoi bambini. Secondo alcuni studiosi, in realtà, l’intenzione della poetessa non era quella di uccidersi, ma soltanto di rivolgere un’estrema richiesta d’aiuto. Sapeva infatti, che quella mattina, sarebbe passata una ragazza che avrebbe dovuto aiutarla con i bambini, quindi le aveva lasciato un biglietto con scritto il numero di telefono del suo medico, e le parole: “Per favore chiamate il dottor Horder”. Hughes si occupò dei beni letterari della moglie, per cui, bruciò completamente l’ultimo volume del suo diario, che descriveva il loro tormentato rapporto, con la scusa che se mai i figli lo avessero letto, sarebbe stato per loro troppo doloroso. Per anni la critica femminista accusò Hughes di aver censurato le pubblicazioni postume della moglie e solo nel 2013, in occasione del 50º anniversario della sua morte, sono emerse le lettere inedite che la scrittrice aveva indirizzato alla sua psicanalista, nelle quali narrava di aggressioni, abusi e minacce di morte subite da parte del marito.

Quella della Plath è un’eredità ingiusta e dolosa, figlia di un amore malato, che ci ricorda quanto possa essere fragile e malvagio l’animo umano. Quindi, cari lettori, ricordate di circondarvi di bellezza e felicità, sempre. E voi autori, non abbandonatevi alla disperazione o all’ansia perché ogni opera merita un suo pubblico. Non prendete decisioni avventate e riponete la vostra fiducia solo in chi realmente la merita, ma soprattutto non abbiate ripensamenti, o rischierete seriamente di ritrovarvi come il pittore e poeta britannico, Dante Gabriel Rossetti, che dovette riaprire la bara dell’amata moglie per recuperare un quaderno di poesie di cui non ricordava più il contenuto.
I libri illeggibili una rubrica a cura di Angela Finelli per The BookAvisor.
Vieni a parlare di libri con tutti noi nel gruppo Facebook The BookAdvisor.

 Libri difficili, opere da evitare e classici mai letti [foto]
Libri difficili, opere da evitare e classici mai letti [foto]